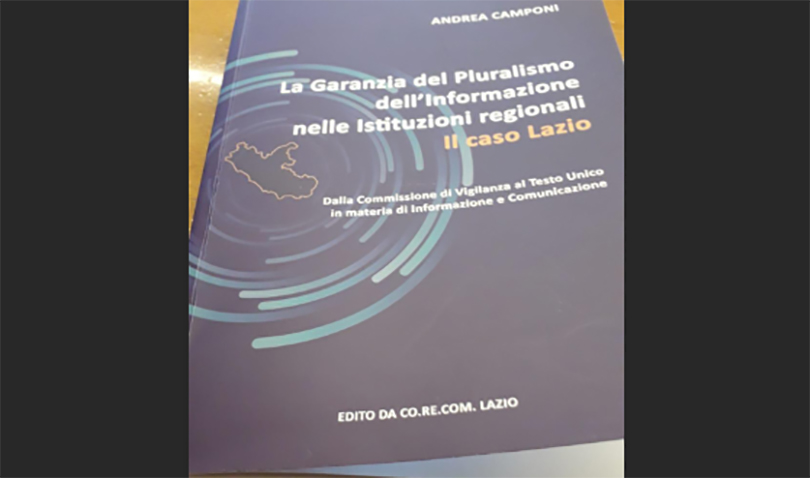Oggi, negli anni Settanta. I Wolfmother concludono stasera all’Atlantico il loro minitour italiano di tre tappe, che nei giorni addietro li ha portati a Vigevano prima e a Padova poi. Procedono al ritmo di un bradipo però i lavori per il nuovo album, il terzo dal 2006, quando uscì il loro debutto omonimo. Fu allora che il gruppo australiano capitanato dal ricciolutissimo Andrew Stockdale sbancò le hit parade internazionali grazie a una miscela di sound squisitamente psichedelica e retrò, tutta intrisa di melodie lunghe, lunghissime e acuti stile Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.
Un mix così antico da essere sfacciatamente all’avanguardia. Old is the new young. Ora che da quel disco è passata poco più di mezza decade, in fondo è già cambiato tutto. Cinque anni, in effetti, nell’era tecnologica sono una vita. Pensiamo a “Cosmic Egg” per esempio, il loro secondo lavoro che trae il titolo da una posizione Yoga chiamata appunto uovo cosmico. Era il 2009 e l’unico superstite della band originaria, a soli 36 mesi dai fasti di inizio carriera, altri non era che lo stesso Stockdale: frontman e anima indiscussa del gruppo. O dei gruppi, perché di questo stiamo parlando. Neanche fossero un’automobile da cambiare non appena finito il finanziamento. Da masochisti. Attorno a Andrew – “il vostro affezionatissimo” – è stata completamente ristrutturata la line up degli esordi, con gli innesti di Ian Peres alle tastiere, Aidan Nemeth alla chitarra ritmica e Dave Atkins, polistrumentista che viene dall’hip hop alternativo, alla batteria; oltre che affidata la produzione a uno specialista di psichedelia e impatto muscolare come Alan Moulder (il suo ruolino di marcia parla chiaro: Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, ma anche, agli albori, My Bloody Valentine e Jesus and Mary Chain).
Il risultato però non è affatto rivoluzionario, anzi s’è persa per strada quella freschezza “ossimorica” che si basava proprio sul culto puro ed estetico del passato: un riproporre alla lettera, e alla nota, sonorità e atmosfere seventies senza metterci sopra neanche un briciolo di contaminazione “modevna”, per dirla con Elio quando parla di amari in tv. Una visione-retrovisione, quella dei primi due anni di vita del gruppo, magari un po’ kitsch, ma proprio per questo efficace. Oggi invece i Wolfmother registrano con un suono più aspro e fumoso, sporcato da influenze stoner e neworientali, come anche dagli anni di esperienza – pochi ma buoni – messi ormai sul groppone. Non ci sono più hit totali del calibro di “The Joker and the Thief”, “Mind’s Eye”, “Witchcraft” o ancora “Woman” ed è scomparsa quella “didattica d’esecuzione” che li rendeva autentici cultori naìf dell’anacronismo, dell’atemporalità e dell’atarassia nei confronti del progresso.
Insomma, col loro volersi distinguere hanno finito in realtà per cedere al banale. Mentre erano assolutamente unici quando si limitavano a riprodurre. A rivivere, rivivendo in prima persona. Giudizi a parte però – de gustibus – resta un fatto: dal vivo, oggi, una band come la loro, amanti e non del genere, nostalgici e non degli anni Settanta, non si può non andare a sentirla. Nella speranza di un futuro migliore, e nella consapevolezza che il passato è migliore.
Francesco Gabriele